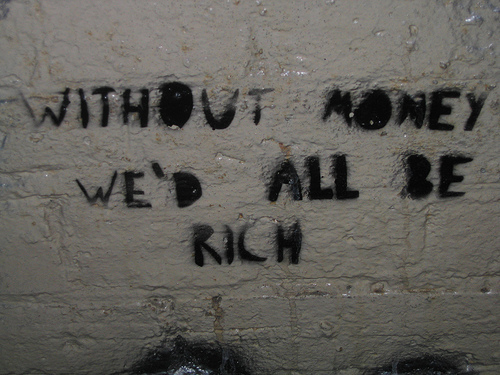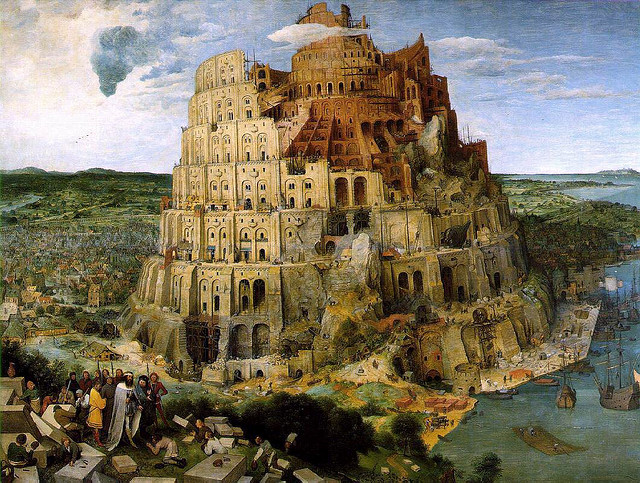Martedì 15 febbraio, qui a Milano, parteciperò a due eventi interessanti dal punto di vista della wikicrazia, cioè della riprogettazione partecipata del mondo in cui viviamo.
Martedì 15 febbraio, qui a Milano, parteciperò a due eventi interessanti dal punto di vista della wikicrazia, cioè della riprogettazione partecipata del mondo in cui viviamo.
La giornata (a partire dalle 9.30) è dedicata al convegno sul design dei servizi organizzato dall’Associazione per il Design Industriale e dal Politecnico di Milano (programma e invito qui). Sono anche relatore: gli organizzatori considerano Kublai un servizio ben progettato, e in questo senso io e il mio team ne saremmo i designer. Siamo anche metadesigner, perché un’altra relazione racconterà CriticalCity Upload, incubato proprio dentro a Kublai.
La serata è dedicata a un esperimento molto intrigante. Pietro Speroni, matematico e supergeek, ha inventato un modo per trovare risposte condivise a domande aperte, basato su quelli che lui chiama “algoritmi genetici umani”, e ne farà un collaudo insieme agli intervenuti. L’idea è questa: c’è una domanda. Chiunque può dare una risposta. Tutti votiamo le risposte (“Sì” o “No”). Un software esamina la votazione e ne trova il cosiddetto fronte di Pareto, cioè l’insieme delle risposte non dominate: significa che una risposta che ha avuto il voto di Anna e Beatrice verrà scartata se ce n’è almeno un’altra che è stata votata da Anna, Beatrice e Carlo. Si dice che la seconda risposta “domina” la prima, perché ha tutti i votanti della prima più almeno uno. Fatto questo, si chiede ai partecipanti di riscrivere, usando – se lo vogliono – i pezzi delle risposte selezionate nel primo round. Questo dà luogo a una seconda generazione di risposte, che usano il “materiale genetico” già selezionato, su cui di nuovo tutti votano e il software cerca il fronte di Pareto, e si itera fino a che non evolve una sola risposta dominante. Il software, naturalmente, si chiama Vilfredo.
Gli esperimenti di Pietro e del suo gruppo finora hanno mostrato che l’algoritmo genetico umano converge. In un certo senso converge troppo in fretta: Vilfredo arriva a un’unica risposta dominante in dieci generazioni o meno, mentre gli algoritmi genetici in senso stretto convergono in diecimila generazioni. E ti credo: l’evoluzione deve provare tutte le mutazioni alla cieca, e lasciare che i vicoli ciechi genetici portino all’estinzione, mentre la discussione tra umani scarta a priori un gran numero di alternative. Se la domanda è “cosa facciamo stasera?”, per esempio, le risposte tipo “dichiariamo guerra al Guatemala” o “andiamo tutti a fare il bagno nel piombo fuso all’Italisider” non hanno bisogno di essere discusse e poi scartate, ma proprio non compaiono mai. Questo dovrebbe insegnarci che i modelli di emergenza nel mondo fisico (i cui agenti sono stupidi, come i neuroni o le formiche) sono molto diversi da quelli del mondo sociale (i cui agenti sono persone, e quindi intelligenti). Alle 20.00 a Musicopoli, Via Boifava 29/A (evento Facebook qui). Potete dire tutto, ma non che non viviamo in tempi interessanti.Pietro and his group have been experimenting, and so far the human genetic algorhythm always converges. In a way it converges too fast: Vilfredo gets to an unique dominant answer in ten generations or less, whereas non-human genetic algorhythms need more like ten thousands generations to converge. Makes sense: evolution has to blindly try every conceivable mutant and let genetic cul-de-sacs go extinct, whereas human discussion can discard a priori a lot of unpromising alternatives. If the question is “what shall we do tonight?”, answers like “let’s declare war to Guatemala or “let’s all go bathe in molten lead” don’t need to be discussed and discarded: they just never come up. This should teach us that emergence in the natural world (where agents are dumb, like neurons or ants) is very different from emergence in the social world (where agents are smart, like people or companies). At 8 p.m. at Via Boifava 29/A (Facebook event). You can say anything, but not that we don’t live in interesting times.