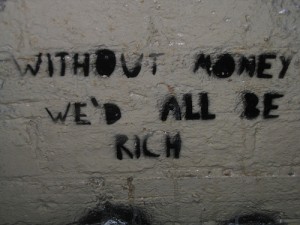Sto lavorando alla costruzione di una nuova comunità online, che si chiamerà Edgeryrders. È un’attività ancora relativamente nuova, affidata a un sapere ancora non del tutto codificato. Non c’è un manuale di istruzioni che, eseguite, ti garantiscono i risultati: alcune cose funzionano ma non sempre, altre funzionano più o meno sempre ma non capiamo perché.
Non è la prima volta che faccio cose del genere, e sto scoprendo che anche in un campo così complesso e meravigliosamente imprevedibile si può imparare dall’esperienza, e come. Alcune delle iniziative di Edgeryders sono riadattamenti dell’esperienza Kublai: il crowdsourcing del logo, e il reclutamento del team a partire dalla neonata comunità, ad esempio. Per altre decisioni mi sono ispirato a progetti non miei, come Evoke o CriticalCity Upload; e molto mi hanno insegnato gli errori, sia miei che altrui.
È un’esperienza strana, esaltante e umiliante al tempo stesso. Sei il crowdsorcerer, l’esperto, colui che può evocare ordine e senso dal magma della rete. Tu ci provi: pronunci le formule, agiti la tua bacchetta magica e… qualcosa emerge. Oppure no. A volte tutto funziona benissimo, ed è difficile resistere alla tentazione di attribuirsene il merito; altre non funziona niente, e per quanto ci provi non riesci a trovare l’errore. E l’errore – come il merito, del resto – potrebbe non esserci: le dinamiche sociali non sono deterministiche, e i nostri migliori sforzi non sono sempre sufficienti a garantire il risultato.
Per come la vedo io, la competenza che sto cercando di sviluppare – chiamiamola crowdsorcery – richiede:
- pensare in probabilità (con varianza alta) anziché in modo deterministico. Un’azione efficace non è quella che, a colpo sicuro, mobilita dieci contributi di buon livello, ma quella che raggiunge mille sconosciuti, di cui novecento ti ignorano, novanta contribuiscono cose di bassissimo livello, nove ti danno cose di buon livello e uno ti scrive il contributo geniale, che ti rivolta il progetto come un guanto e influenza tutti gli altri novantanove (i novecento sono persi comunque). Il trucco è che nessuno sa chi sia quell’uno, neppure lui o lei, fino a che non cominci a sparare nel mucchio.
- monitorare e reagire anziché pianificare e controllare (adaptive stance). Costa meno e funziona meglio: se una comunità ha un tropismo naturale, ha più senso incoraggiarlo e cercare di capire come valorizzarlo che non reprimerlo. Il monitoraggio online è tendenzialmente gratis, anche quello “profondo” alla Dragon Trainer, quindi meglio non risparmiare sulle web analytics.
- costruirsi un arsenale teorico ridondante anziché appoggiarsi sulla linea del pragmatismo (“faccio così perché funziona”). La teoria pone domande interessanti, e trovo che cercare di leggere il proprio lavoro alla luce della teoria aiuti il crowdsorcerer a costruirsi attrezzi migliori. Io sto usando molto l’approccio complexity e la matematica delle reti. Per ora.