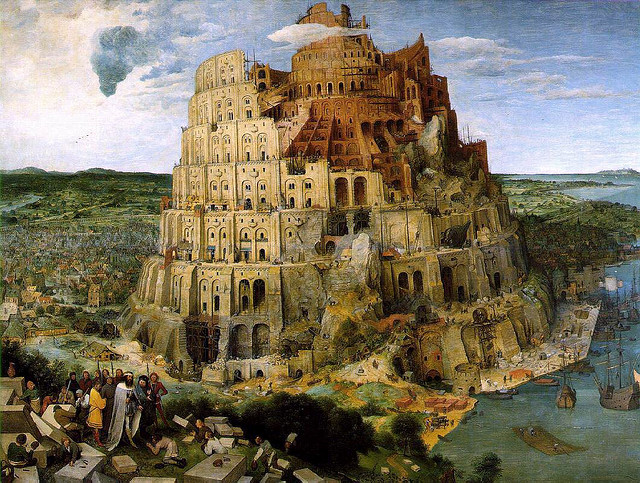Mi sono dimesso da direttore di Kublai, il primo progetto 2.0 dell’amministrazione centrale italiana. La mia direzione era da un anno un interim; la procedura con cui il Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero per lo sviluppo economico (che ne è il committente) si propone di lanciare il terzo anno di Kublai – reclutandone anche un nuovo team e un direttore – ha avuto molti problemi, e ha finito per accumulare oltre un anno di ritardo. Su richiesta del responsabile di Kublai all’interno del Ministero, Tito Bianchi, ho mantenuto una funzione di direzione e rappresentanza (non pagata) in attesa che la situazione si sbloccasse. Nel frattempo il Dipartimento stesso si è trovato a dovere affrontare una crisi non direttamente collegata con le cose che racconto qui: una delle conseguenze è stata che, da febbraio, Tito non è stato confermato nel suo incarico. A questo punto non ci sono le condizioni nemmeno per un interim: sarà Invitalia, che ha un mandato e risorse, a governare Kublai nell’attesa che la procedura di rinnovo del team si concluda. Io continuo a frequentarla come semplice membro della comunità, e continuo a imparare molto dallo scambio di idee con i kublaiani. Mi inorgoglisce moltissimo che, anche in queste condizioni difficili, la comunità mostri una grande vitalità e un profondo apprezzamento per il servizio che Kublai ha fornito in questi anni: in questi giorni si discute su una proposta che la community stessa subentri al Dipartimento nel finanziare e gestire Kublai. Se funziona, sarà un caso praticamente unico di spinoff di una politica pubblica da un’ammistrazione a una comunità online. E anche se non funziona, provarci sarà un’esperienza straordinaria. Per conto mio, sono profondamente grato al Dipartimento per avermi dato l’opportunità di sviluppare un progetto così avanzato.
Al di là del risvolto personale, la storia di Kublai di questi anni mi sembra rappresentativa di una difficoltà strutturale nell’attuazione delle politiche pubbliche: le amministrazioni non riescono a gestire bene lo snodo tra le proprie attività e quelle delle comunità che collaborano in rete. L’azione di governo in rete — e io ne ho progettate e attuate diverse — può essere incredibilmente efficiente, perché abilita i cittadini a contribuire attivamente. A marzo 2009, a dieci mesi dal lancio, uno studio indipendente mostrava che i due terzi dei contributi alla redazione di business plans venivano dalla comunità degli utenti stessa, e solo un terzo dallo staff pagato del progetto. Il segreto di questa efficienza è nell’attivismo della comunità che si raduna intorno al progetto; e i legami di comunità possono spezzarsi in assenza di manutenzione. Un calo del livello di fiducia nei gestori del progetto o un semplice calo di tensione possono fare venire a mancare la motivazione a partecipare in qualsiasi momento.
In questi anni ho dedicato molto tempo a studiare le comunità di policy, soprattutto quelle online, e imparato molto. Ho capito che gestirle bene richiede che alcune condizioni siano presenti:
- un orizzonte di programmazione adeguato; se per costruire una comunità solida ci vogliono tre anni, ti devi prendere tre anni, e in questo periodo la continuità deve essere garantita. Fermarsi prima di ottenere il risultato pieno vuol dire sprecare tuttele risorse investite.
- trasparenza assoluta: l’accesso ai retroscena deve essere garantito a quegli utenti che volessero conoscerli (senza ovviamente imporlo a chi non è interessato). La partecipazione attiva richiede senso di ownership da parte degli utenti, e questo viene meno se abbiamo la sensazione che non ci stiano raccontando tutta la verità.
- costi bassi: un progetto che si regge sul volontariato ha bisogno di mostrare ai volontari che lo staff dà un contributo adeguato ai suoi compensi. Il punto è sensibile, perché la collaborazione tra staff e community è intrinsecamente diseguale — collaboriamo, ma io sono pagato e tu no — ma, se lo staff lavora molto e bene risulta accettabile. Giustificare margini alti, invece, è veramente duro. Ogni euro che viene speso per coprire costi di struttura invece che per le attività indebolisce la credibilità del progetto.
- tempi di attuazione rapidi e certi, e quindi procedure ridotte al minimo. Le dinamiche sociali in rete sono veloci e soprattutto emergenti, non controllate dall’alto, quindi succedono quando succedono, e quando succedono devi agire di conseguenza. Se una cosa serve adesso, devo avere la possibilità di farla adesso; nei casi in cui questo non sia possibile, devo comunque essere in grado di dire quando verrà fatta. “Non so, stiamo aspettando” distrugge credibilità, quindi partecipazione, quindi efficienza.
- abbassamento della barriera tra staff di progetto e comunità. I partecipanti volontari a una comunità online sono le persone più qualificate per diventarne lo staff. La conoscono bene e la amano, ne condividono tempi e luoghi di incontro. Viceversa, assegnare a un progetto come Kublai un lavoratore dipendente, imbrigliato da orari e tornelli e segregato dietro un firewall aziendale che gli impedisce di usare i social network (cioè gli strumenti stessi del lavoro di comunità) significa crearsi un problema.
- tutto questo richiede molta libertà gestionale, e quindi che il progetto sia valutato sui risultati e non sulla conformità alle procedure.
Purtroppo queste condizioni si sposano male con le modalità di lavoro prevalenti nelle burocrazie weberiane – e la maggior parte delle pubbliche amministrazioni sono burocrazie weberiane. Nel caso di Kublai:
- non è stato possibile garantire l’orizzonte di programmazione. Al tempo del varo del progetto, il Dipartimento decise di spacchettarlo in tre annualità da rifinanziare anno per anno. La ragione: un progetto triennale avrebbe richiesto una gara europea, che richiede tempi lunghissimi (un anno e mezzo) per essere completata. I risultati: al secondo anno il progetto è stato sì rifinanziato, ma con modalità che ne riducevano l’efficacia (vedi oltre) e con un gap di tre mesi per l’avvio formale del progetto e di sette per cominciare davvero a lavorare; per il terzo anno abbiamo progettato un’architettura sulla carta più efficace, che utilizzava due canali di attuazione, ma uno di questi non è mai partito. La mia storia personale è un segno della volatilità dei tempi amministrativi: ho diretto Kublai per tre anni, e ho avuto un contratto regolare per sedici mesi in tutto, il resto è stato interim.
- la trasparenza assoluta è tecnicamente difficile. Anche se i decisori pubblici hanno le migliori intenzioni, vivono un sistema così complicato da essere incomprensibile per un esterno. Per esempio, la prima annualità di Kublai è stata affidata a una società in-house dello Stato, Studiare Sviluppo. Per la seconda annualità, l’ufficio legale del Dipartimento ha cambiato idea e sostenuto che questo non era possibile: sebbene il Dipartimento stesso e Studiare Sviluppo avessero un’origine comune nel Ministero dell’Economia, la creazione nel 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico (che contiene il DPS, ma non Studiare Sviluppo) aveva creato una cesura tra le due strutture. L’affidamento andava fatto, invece, a Invitalia, altra società in-house dello Stato. Questa distinzione è difficile da capire e, pare di capire, controversa anche all’interno dello stesso DPS. Infatti nel 2009 alcuni programmi del Dipartimento hanno continuato a passare attraverso Studiare Sviluppo, ma Kublai no. Come la racconti una storia così nella pagina “About”?
- i costi tendono a lievitare. Kublai 2009 ha avuto un budget più alto di Kublai 2008, ma allo stesso tempo è sembrata meno efficace. Perché? In parte perché era cresciuto il ricarico. Studiare Sviluppo ci ha trattenuto il 15% a fronte dei suoi costi di struttura; il ricarico di Invitalia è più difficile da stimare e varia a seconda del progetto, ma in genere si attesta tra il 30 e il 40% (fonte: diversi funzionari del Dipartimento. Ho chiesto un dato preciso a Invitalia e sono in attesa di risposta).
- i tempi sono sempre lunghi, e sempre soggetti a incertezza. Per darvi un’idea, Kublai 3 sarebbe dovuta partire a gennaio 2010. L’idea era di attivare un progetto affidato a Invitalia, e usarlo come cofinanziamento di un secondo progetto, più ampio, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Questo, però, avrebbe richiesto una modifica del sistema di contabilità industriale di Invitalia (nei progetti FESR il lavoro deve essere rendicontato al costo diretto, al netto del margine di cui sopra). A maggio si è capito che Invitalia non poteva o non voleva effettuare questa modifica in tempi brevi (mi dicono che il processo sia ancora in corso). Tito ha dovuto attivare una seconda procedura che attingesse a una diversa fonte finanziaria; avviata in giugno, si è mossa con grande lentezza e con la sensazione chiarissima di navigare a vista. Pensavamo che l’avremmo completata a settembre, poi a novembre, poi a febbraio; sono stati fatti diversi annunci in questo senso sul blog di Kublai, poi smentiti dai fatti. A febbraio, d’accordo con Tito, abbiamo fatto outing. La verità è che nessuno è in grado di dire cosa succederà e quando.
- nel primo anno di Kublai siamo riusciti a usare la flessibilità di Studiare Sviluppo per reclutarne il community staff dalla comunità, con piccoli contratti che riconoscevano e incoraggiavano il lavoro volontario senza costringere i creativi a trasformarsi in consulenti della pubblica amministrazione per lavorare a Kublai. Questo andava nella direzione di abbassare le barriere tra “professionisti” e “cittadini impegnati”, e costruire un clima di equità, in cui non possa succedere che di due persone che fanno più o meno le stesse cose una è pagata e una no. A partire dal 2009 questo processo si è bloccato: le regole interne di Invitalia sono che solo una parte molto limitata del lavoro può essere affidata a personale esterno (il 15% dei costi di personale nel caso di Kublai); inoltre, le procedure di reclutamento sono molto lunghe (mesi) e strutturate, e tutti i contratti devono essere firmati dall’amministratore delegato. Risultato: il carico amministrativo di fare tanti piccoli contratti da mille o duemila euro era semplicemente insostenibile. Abbiamo dovuto polarizzare molto i collaboratori di Kublai: da un lato i lettori di business plan professionisti (dipendenti pubblici o parapubblici, che in genere apprezzano la stabilità offerta da un posto fisso e hanno poca o nessuna esperienza di creazione di impresa, tantomeno di impresa creativa), dall’altro i creativi veri, a cui non potevamo pagare nemmeno le spese di viaggio per rappresentare Kublai a un convegno.
- quanto alla valutazione, Tito e io avevamo inserito un’attività di valutazione strutturata in Kublai 3, che però, appunto, è bloccata; il progetto rischia quindi di non venire valutato.
Con tutti questi problemi c’è da meravigliarsi che il progetto non sia nato morto! Se qualche risultato abbiamo comunque ottenuto (2500 utenti registrati per 400 progetti in discussione e decine di imprese e progetti lanciati non sono uno scherzo) è perché alcune persone si sono spese ben oltre i limiti del ragionevole. Il mio staff è stato generosissimo, trasformando il lavoro in volontariato quando i contratti scadevano e non venivano rinnovati (vanno assolutamente citati Cristina Di Luca, Walter Giacovelli e Marco Colarossi); i referenti di Kublai al Dipartimento (Paola Casavola, all’epoca il direttore generale responsabile dell’iniziativa, Tito Bianchi, Marco Magrassi e Giampiero Marchesi su tutti) hanno espresso una committenza competente e visionaria (Tito in particolare ha fatto veramente i salti mortali per Kublai); Alfredo Scalzo a Studiare Sviluppo e Nicola Salvi, Federico Venceslai, Angelita Levato e Danila Sansone a Invitalia hanno usato a fondo l’autonomia che le rispettive aziende concedevano loro per cercare di venire incontro alle esigenze del progetto. Siamo stati una banda corsara, un po’ Luke Skywalker e un po’ Fantozzi: mi ricordo, per esempio, Nicola che postava su Kublai dal suo laptop e navigando a prestito dal wi-fi del vicino, perché il firewall aziendale gli inibiva Second Life. Nonostante tutto questo impegna, eravamo un equipaggio competente e motivato alla guida di una barca che faceva acqua da tutte le parti. Quando sono scaduti i contratti dello staff esterno, il più libero dalle regole burocratiche, nonostante abbiamo in parte compensato svolgendo lavoro volontario il calo di tensione è stato evidente.
Una conclusione che ho tratto da questa esperienza straordinaria è che l’interfaccia tra burocrazia e rete è difficile, molto. Kublai si può vedere come un tentativo per fornire in coproduzione e attraverso Internet un servizio pubblico, quello di assistenza alla redazione di business plans per la nuova impresa, che tradizionalmente viene fatto (non troppo bene) a sportello. È un tema caldissimo: è, per esempio, uno degli obiettivi decisivi del Public Services Lab di NESTA, con cui mi sono confrontato negli ultimi tempi. Dal mio punto di osservazione al Consiglio d’Europa, tutti i governi europei si stanno muovendo in questa direzione, per cercare di tenere in piedi un minimo di welfare a fronte di una forte crisi fiscale. Presto la moda arriverà in Italia, ma sarà difficile ottenere risultati duraturi se le condizioni che ho elencato non saranno garantite.
E per garantirle, temo, vedo solo una possibilità: un new deal tra la pubblica amministrazione e le donne e gli uomini che lavorano per essa. Il new deal funziona così: la PA deve dare fiducia e spazio per lavorare ai suoi servitori, siano essi dipendenti o consulenti esterni; e poi valutarne i risultati, premiare chi fa bene e punire chi fa male. Se ci sono abusi, si affronteranno caso per caso: progettare un intero sistema con l’obiettivo di prevenirne i possibili abusi rischia di renderlo rigido e disfunzionale. Chi progetta social media sa bene che, se progetti un sistema per gestire i troll, i tuoi utenti saranno troll. Allo stesso modo, se progetti procedure amministrative a misura di persone pigre e disoneste, gli elementi migliori, frustrati e umiliati, ti abbandoneranno, e resterai con i pigri e disonesti. È il momento di scegliere: per quale utenza saranno progettate le politiche pubbliche del futuro?