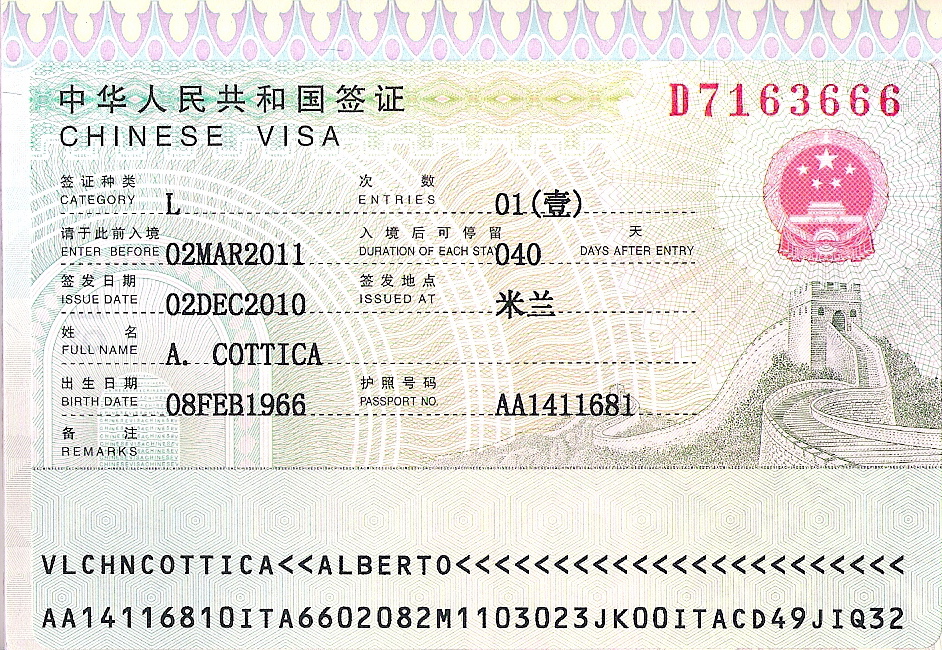Quando mi sono messo a fare il musicista professionista – era la metà dei ’90 – i miei genitori non hanno esattamente stappato lo champagne. Rispettavano il mio percorso (non che avessero molta scelta), ma temevano che sarebbe stato faticoso, forse anche doloroso.
Quando mi sono messo a fare il musicista professionista – era la metà dei ’90 – i miei genitori non hanno esattamente stappato lo champagne. Rispettavano il mio percorso (non che avessero molta scelta), ma temevano che sarebbe stato faticoso, forse anche doloroso.
In effetti, l’economia creativa rende il mondo un luogo molto più brillante, colorato, piacevole. Ci stimola tutti quanti, e dà a chi riesce ad affermarvisi un ruolo davvero invidiabile, quello di chi riesce ad affermarsi percorrendo strade insolite, scommettendo sulla propria unicità, facendo mosse inaspettate che il normale mercato del lavoro non sa come valutare. Ma tutto questo ha un prezzo: per ogni successo ci devono essere almeno dieci fallimenti. Più persone ci proveranno, più saranno quelli che hanno successo, e meglio andranno le cose per tutti noi: ma il crescente incoraggiamento ai giovani a provarci, il fiorire dei premi per la creatività e degli aggregatori di talenti moltiplica anche il numero dei fallimenti. Alcune persone falliscono il primo e magari anche il secondo progetto, fanno tesoro di queste esperienze e indovinano il terzo: ma, inevitabilmente, sono molti più quelli che, dopo uno o più fallimenti, abbandonano il campo, e devono ripensarsi, reinventare un’identità meno intrigante di quella di creativo. Fatevelo dire da uno che ha passato veramente tanto tempo a chiedersi “ma sarò capace? mi sto illudendo sulle mie capacità? a chi interessa davvero ciò che sto facendo?”: è un processo che ha un costo umano notevolmente alto.
E quindi, quando leggo una storia come quella di Walter Giacovelli, ci rimango male. Fare impresa creativa già è difficile in condizioni ottimali: con il sistema paese che rema contro diventa quasi impossibile. Walter, comprensibilmente esasperato dalla galleria degli orrori che fa da sfondo al suo percorso (presenta un progetto sui social media e gli dicono che quell’anno si finanziano solo progetti sull’agricoltura; lavora per IG Students, ma il programma chiude senza pagare i collaboratori; è sempre troppo precoce, o troppo anziano, o “non presenta i requisiti di soggetto svantaggiato”) è arrivato a darsi un ultimatum: o si parte entro cento giorni, o si ammaina la bandiera.
Onore alla bandiera, comunque andrà. So bene che non si possono eliminare le sconfitte dal sistema senza fermarlo del tutto, e so anche che alle sconfitte si sopravvive e si va avanti. Lo so sulla mia pelle, perché le ho subite anch’io (questa, per esempio). Però si può e si deve pretendere da noi, che progettiamo e attuiamo le politiche per la creatività, che ci accostiamo con rispetto ed empatia alle persone che, là fuori, lottano e sognano, e spesso pagano salato. Che ci interroghiamo sempre sul senso di quello che stiamo facendo. Che non ci creiamo microfeudi, non chiediamo esclusive, non pensiamo mai di avere capito tutto. Che non ci abbandoniamo alla retorica (io comincio a stancarmi di sentire ripetere a caso “creatività”, “giovani”, “talento”, “innovazione”). E che sfruttiamo al massimo ogni euro, ogni minuto di tempo per cercare di mettere tutti in condizioni di provarci al meglio.
Niente di nuovo, lo so. Ma tenere la guardia alta è utile anche se non è nuovo.